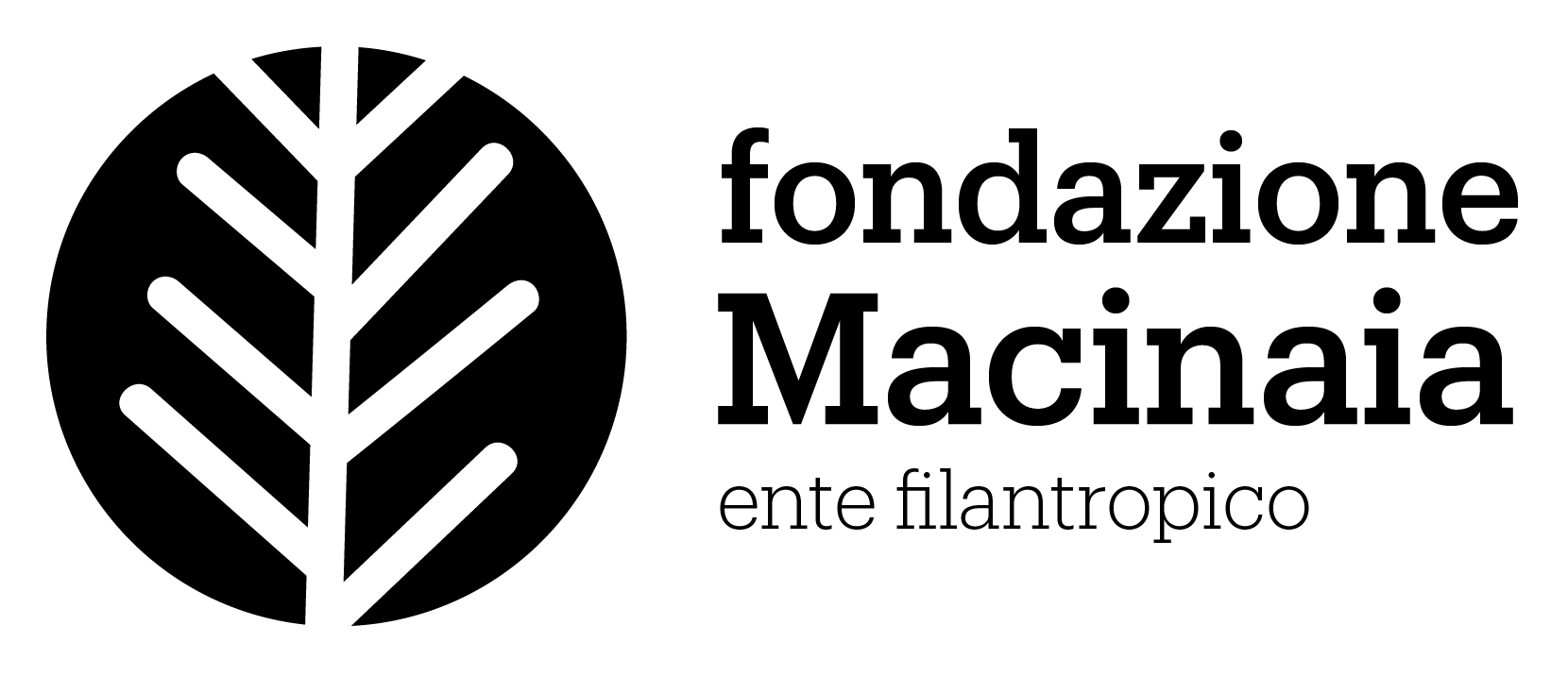In una società dove da decenni si assiste alla graduale frantumazione dei legami tradizionali facendo emergere le tante difficoltà inerenti al ruolo educativo dei genitori, anche le riflessioni sull’argomento si sono via via intensificate allo scopo di comprendere e provare a trovare una via di uscita da una condizione di profondo disorientamento.
Sono passati molti anni da quando Donald Winnicott ha coniato quell’espressione felice che metteva i genitori in una condizione di umana accettazione dei propri limiti dopo che lo stesso Sigmund Freud aveva definito impossibile il mestiere di genitore.
Non era necessario essere perfetti genitori ma sufficientemente buoni.
Espressione ripresa successivamente da tanti altri studiosi della funzione genitoriale fuori e all’interno della famiglia, tanto che se n’è fatta quasi un manifesto continuamente evocato, sorvolando però su una questione fondamentale che, per essere sufficientemente dei buoni genitori, è indispensabile attraversare il buio delle nostre caverne per arrivare a una maggiore consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo.
Compito assai arduo e non per tutti.
Per questo negli ultimi anni si è fatto spazio un approccio più pragmatico centrato sugli stili comunicativi, linguistici e comportamentali con la diffusione di testi che offrono istruzioni per l’uso: i ‘no’ che aiutano a crescere, quanti sì e quanti no per crescere bambini felici, come sopravvivere con un adolescente in casa, gestire la rabbia senza perdere la calma, eccetera.
A partire dal graduale processo di individualizzazione della società e la conseguente condizione di solitudine in cui si trovano a vivere le famiglie, alcune analisi recenti riflettono sulla tendenza a crescere bambini capaci di adattarsi alle eccessive aspettative sociali centrate sulla performance, secondo un modello narcisistico o postnarcisistico del quale gli adulti fragili sono trasmettitori impotenti.
Inoltre, alcuni esperti del settore, forti della loro risonanza mediatica e della loro indiscutibile esperienza, non perdono occasione di bacchettare i genitori per la loro “mollezza”e perdita di autorità diventando gli amici dei loro figli e per uno stravolgimento generazionale di adultizzarli precocemente con i conseguenti problemi psicologici che ne derivano.
Ma mai prima d’ora i genitori si sono trovati a dover arginare fenomeni così potenti come la diffusione di internet e la perdita di punti di riferimento per la scomparsa dell’universo valoriale garantito dalla presenza della famiglia allargata e del “villaggio”.
Mai prima d’ora i bambini e ragazzi si sono trovati esposti alla mole di tentazioni che caratterizzano i nostri tempi, inondati da un flusso costante e onnipresente di stimoli seduttivi derivanti dalla società dei consumi, tentazioni dannose che creano dipendenza rese ancora più attraenti a causa della loro diffusione attraverso mezzi pubblicitari che raggiungono i nostri figli a tutte le ore del giorno e della notte attraverso gli smartphone.
Proprio nel momento in cui sono così gravemente esposti ai pericoli, vi è stato un drastico indebolimento della condizione genitoriale, a causa di cambiamenti di vasta portata avvenuti nella struttura sociale e nei valori educativi.
In tali situazioni i genitori disorientati faticano a trovare una base solida e stabile per svolgere la loro genitorialità e questa fragilità aumenta le possibilità che il bambino a sua volta non trovi in papà e mamma significativi punti di riferimento.
I genitori sono più deboli principalmente perché sono più soli.
Mai si sono trovati davanti a sfide così complesse per le quali il sentirsi disorientati rappresenta una condizione comprensibile ed inevitabile.
La vera sfida è di ricercare un cambio di paradigma individuando una nuova autorità contrapposta alla vecchia attraverso interventi a sostegno dei genitori tesi a rafforzare autocontrollo, perseveranza e autenticità, riconoscendo le fragilità legate alla complessità del presente e allo stesso tempo la necessità di recuperare un ruolo di àncora per i loro figli.
Ricostruire una nuova autorità è un processo di lunga durata che presuppone un atto di coraggio volto a una conversione della coscienza collettiva per provare a rifondare un’ alleanza tra genitori ed istituzioni educative.
A questo, ciascuno di noi è chiamato a contribuire alimentando un clima di fiducia nel cambiamento piuttosto che affondare le unghie con dannose contrapposizioni che rilevano incapacità e colpe, come se non fossimo tutti coinvolti in quello che oggi viviamo come irreversibile deriva educativa.
Nell’incontro con i genitori, in contesti educativi e in consulenza familiare, ho riscontrato che l’empatia, la sospensione del giudizio e l’accoglienza incondizionata sono strumenti estremamente efficaci per fare emergere in loro potenzialità inaspettate e la volontà di assumere un ruolo di adulti responsabili capaci di gestire una relazione positiva con i loro figli, provando a essere genitori sufficientemente buoni a partire proprio dalle loro diverse storie di fragilità.
Cristina Masti
Fondazione Macinaia e Consulente A.I.C.C.e F.