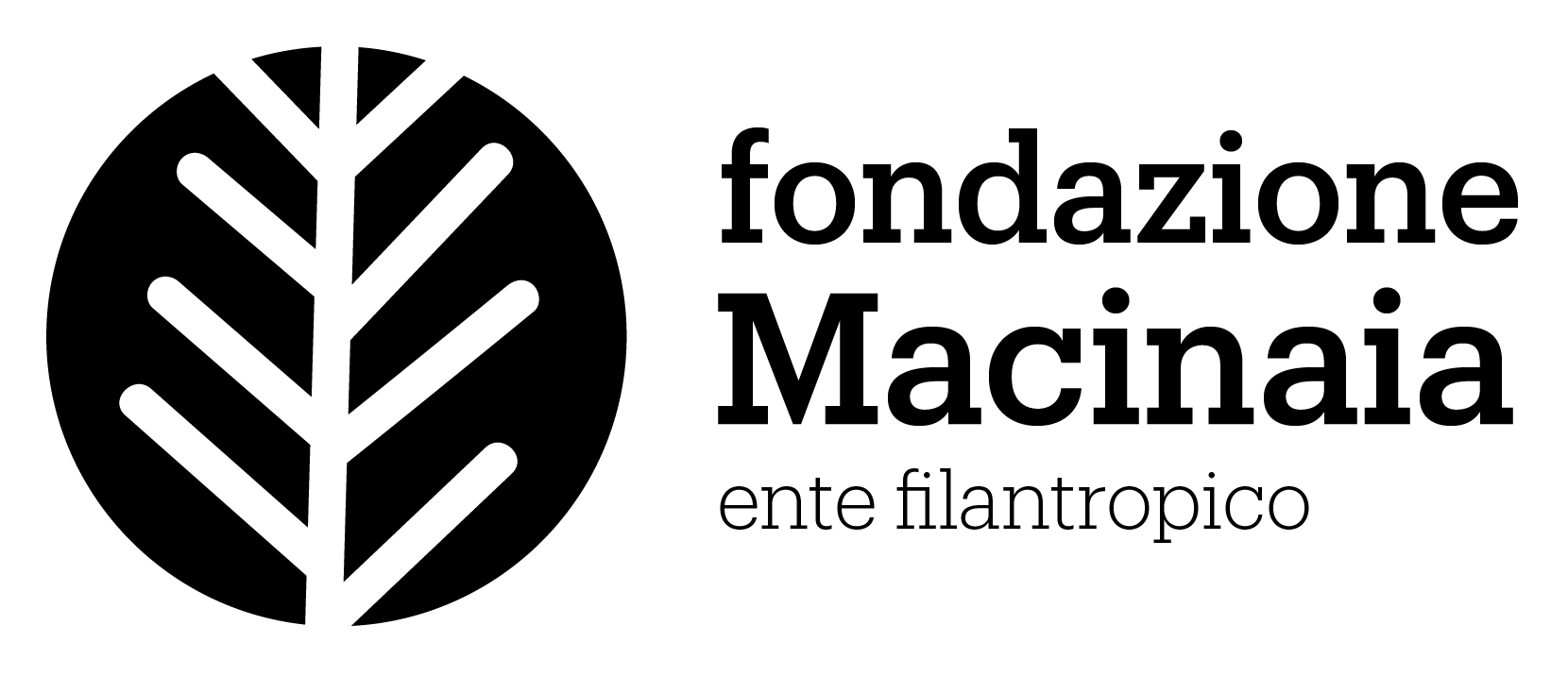da NON SIAMO CAPOLAVORI. IL DISAGIO E IL DISSENSO DEGLI ADOLESCENTI
di Marco Rovelli (editori Laterza, 2025) pag. 75 / 76
Nella famiglia affettiva e adolescente, i ruoli affettivi sono diventati permeabili, perdendo i propri confini: la funzioni paterna e materna sono più intercambiabili di un tempo e genitori che si vivono e vengono vissuti come giovani spesso tendono a un rapporto più amicale e confidenziale con figlio e figlia, ciò che però può essere da ostacolo per la loro autonomia. In questo sistema-famiglia, il figlio concentra su di sé aspettative e diventa oggetto di proiezioni (narcisistiche) del genitore, il quale finisce per considerarlo una propria estensione. A orientare tutta l’azione educativa -ciò per cui si può parlare a buon diritto di “narcisismo familiare“- è il progetto della realizzazione sociale del figlio, del suo successo, mettendogli a disposizione ogni risorsa possibile. E se il figlio è come un’estensione narcisistica del genitore, il quale non può accettare di fallire in quanto ‘buon genitore’, non può e non deve deludere le aspettative in lui riposte. Il figlio deve corrispondere a quelle attese, deve essere la testimonianza incarnata dell’essere stato buon genitore dei genitori. Di fatto non esiste come un sé autonomo, m è uno specchio dei genitori, dovendoli far sentire amati per le risorse affettive e materiali che hanno investito in lui: “Sii te stesso a modo mio”, sintetizza lo psicologo Matteo Lancini– presidente dell’Istituto Minotauro dopo Charmet. Gli adolescenti di oggi devono farsi carico anche della fragilità genitoriale che moltiplica la propria: questo è un elemento decisivo nella costellazione delle “patologie narcisistiche” che si sono intensificate nell’epoca in cui la prima generazione educata nell’era del Narciso ha procreato (…)
Il punto dolente, per un adolescente, è la mancata costruzione della propria identità, perché ha appreso a essere se stesso come vogliono gli altri, interiorizzando aspettative e ideali. I genitori della famiglia affettiva fanno molta fatica a riconoscere l’autonomia del figlio, a riconoscerlo in quanto altro, in quanto soggetto portatore di bisogni specifici. Come osserva Lancini, si tenta di entrare nella sua mente spiegandogli come è fatto e come si sente: non siamo più nell’epoca del Devi obbedire ma del Devi capire, dell’adesso ti spiego come sei fatto, come funzioni e come devi funzionare.
Ne seguono forme marcate di iperadattamento alla volontà genitoriale. Al figlio è implicitamente richiesto di far sentire agli adulti, narcisisticamente fragili, che tutto va bene. E quello che non possono dire, alla fine, lo dice il corpo con specifiche forme di sofferenza.