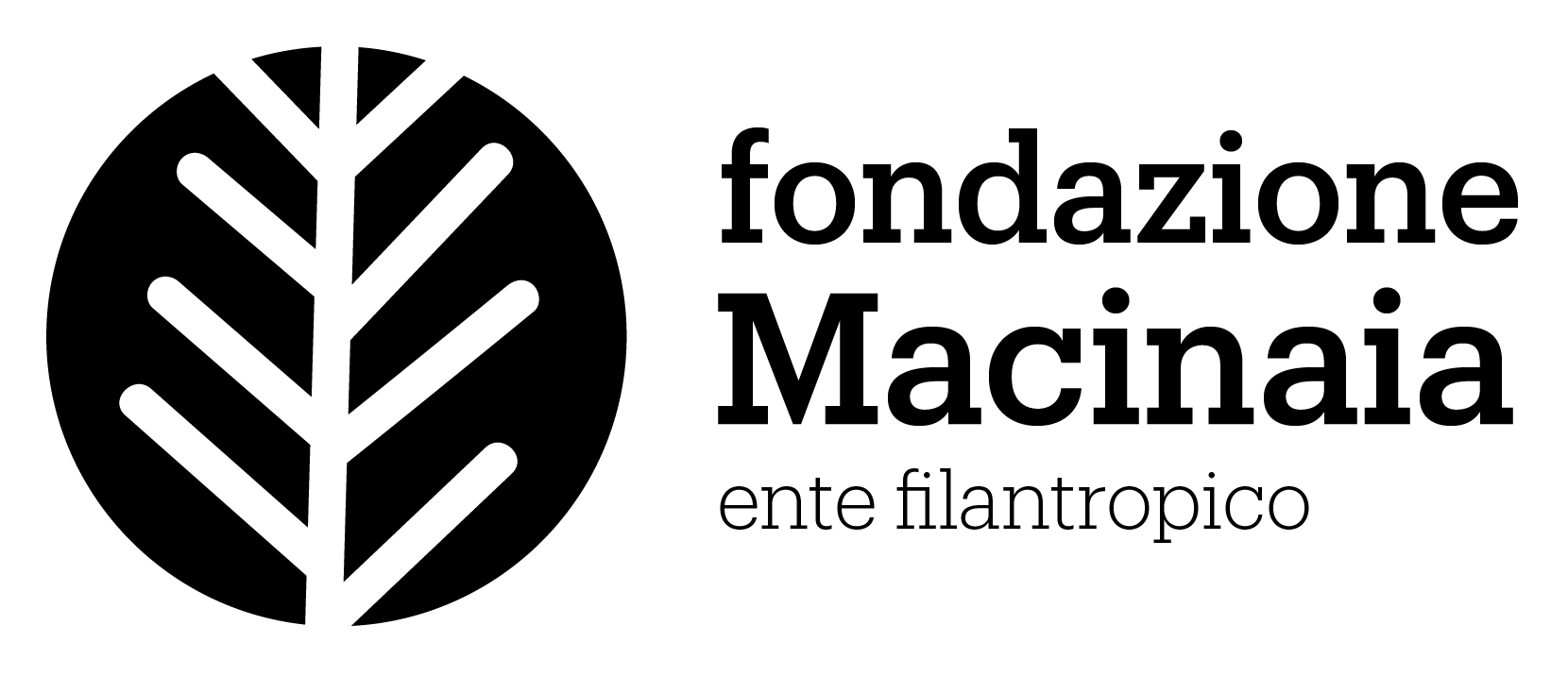Nel numero 2/205 di Animazione Sociale troviamo un focus interessante sulla disabilità. Riportiamo alcuni passaggi degli interventi di Carlo Lepri, Carlo Francescutti e Maurizio Colleoni.
SCRIVERE A MATITA I PROGETTI DELLE PERSONE
di Carlo Lepri e Carlo Francescutti
Se consideriamo il dibattito degli ultimi anni in materia di politiche socio-sanitarie ed educative per le persone con disabilità, con particolare riferimento alle persone con disturbi dello sviluppo intellettivo, dobbiamo constatare che la ‘progettazione personalizzata‘ è stato l’argomento predominante (…)
La progettazione personalizzata rappresenta il riconoscimento del fatto che ciascuna persona ha diritto a costruire la propria vita in relazione con gli altri e con il mondo e, a questo fine, deve poter disporre dei sostegni appropriati (…)
La definizione ‘progetto di vita‘ compare nel vocabolario della disabilità a metà degli anni ’70 del secolo scorso in relazione a due avvenimenti storici: l’avvio del processo di inclusione scolastica, con il superamento delle scuole speciali, e l’inizio delle prime esperienze di inserimento lavorativo e di vita indipendente (…)
Sappiamo che la vita, quando è immersa nella comunità e nelle relazioni, è una continua sorpresa e la prevedibilità dei fatti è solo una consolante illusione. A riguardo da tempo si è compreso che è proprio nelle pieghe di questa imprevedibilità che si nasconde una straordinaria ricchezza di opportunità per la crescita delle persone. “La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare dei progetti” recita una famosa frase ripresa da John Lennon per scrivere una canzone per suo figlio (…)
Il ‘progetto di vita‘ è diventato così una specie di magica parola d’ordine la cui continua evocazione si carica di una fastidiosa e pericolosa enfasi retorica (…)
Nel caso specifico delle persone con disabilità intellettiva è ancora più evidente che il progetto di vita non può essere circoscritto a un unico momento carico di ‘incredibili aspettative‘, ma deve essere un itinerario relazionale che si sviluppa lungo tutto l’arco di vita. (…) Per questo qualunque progetto che riguarda il futuro di una persona andrebbe ‘scritto a matita‘, in modo da poter essere aggiornato il più rapidamente possibile in relazione a come evolvono gli accadimenti auspicati e a come incidono quelli imprevisti. Una visione molto distante da come viene oggi presentato il dispositivo del ‘progetto di vita‘ il quale, più che migliorare la qualità della vita delle persone, sembra destinato ad aumentare il livello dei contenziosi giudiziari.
L’enfasi retorica che connota ‘il progetto di vita’ e le tecniche valutative che dovrebbero accompagnarne la formulazione, se per un verso ha determinato una semplificazione del dibattito sulla personalizzazione, per un altro ha lasciato in ombra una questione decisiva: quella del sistema di offerta dei servizi o, con altro linguaggio, il sistema dei sostegni (…)
Ci interroghiamo molto sull’intelligenza delle persone con disabilità e sui sistemi con i quali valutarle, perché non poniamo lo stesso impegno a interrogarci sull’adeguatezza dei nostri servizi di sostegno e delle nostre pratiche professionali? (….)
Avremmo bisogno di un ‘catalogo‘ dei sostegni fortemente ancorato alle differenti necessità che le persone incontrano nel loro percorso di socializzazione (…)
Non può darsi un’enfasi sulla progettazione personalizzata e un sistema di servizi statico. Dobbiamo decentrare il sistema se vogliamo centrarlo sulla persona. In caso contrario ci stiamo solo ubriacando di parole e di slogan.
SE IL DESIDERIO (E NON IL BISOGNO) E’ IL PERNO DEI PROGETTI DI VITA di Maurizio Colleoni (Animazione sociale b. 2/2025)
Un elemento che mi sembra interessante sottolineare rispetto al possibile valore del progetto di vita è il fatto che, insieme a tanti altri elementi che si sono affermati nel recente passato, introduce un orizzonte culturale che stimola a leggere la convivenza con una qualche disabilità innanzitutto e soprattutto come condizione umana, come modo di esistere e di costruire congruenze soddisfacenti con se stessi, gli altri e la realtà (…)
In un certo senso, è il riconoscimento del diritto all’essere e al divenire, cioè alla possibilità di costruirsi una soggettività all’interno della trama della vita sociale e civile del proprio territorio.
Una chiave possibile per incontrare le persone con disabilità come persone e non solo come ‘malate‘ o ‘mancanti‘ di qualcosa è quella del desiderio, cioè della spinta vitale che orienta le energie e sostiene possibilità di crescita e di miglioramento di sé. Tutti noi, comprese le persone con disabilità, siamo essere desideranti. E quindi anche queste persone possono imparare a capire cosa desiderare per incrementare il proprio benessere e organizzarsi di conseguenza. Quella del desiderio è un’area di lavoro che mi sembra fertile. Innanzitutto perché è un elemento sempre presente, anche nelle situazioni con danni cognitivi profondi; e inoltre perché implica il riconoscimento e il coinvolgimento della persona nella costruzione di percorsi vitali sensati. Istituisce una relazione che si basa sul riconoscimento di una soggettività in azione, frutto di un dinamismo esistenziale che evolve nel tempo, grazie alle esperienze e alle relazioni.
Una prima conseguenza metodologica che deriva da questa ipotesi riguarda la persona in questione, e cioè il fatto che, in questa prospettiva, diventano centrali elementi di benessere esistenziale e di autenticità della vita, più che le dimensioni riabilitative, riparatorie, terapeutiche (…<9
Voglio ricordare che la qualità della vita non coincide necessariamente con la riabilitazione e il superamento del danno. Come per tutti, anche nella disabilità la dignità e la qualità della vita sono il frutto delle esperienze e delle relazioni che si attivano tutti i giorni dentro la realtà, anche quando c’è di mezzo una qualche limitazione alle proprie autonomie. Le dimensioni riparative prendono senso in relazione alla crescita della qualità esistenziale (…)
Le persone non sono la loro diagnosi, anzi ritengo che le diagnosi non riescano a rendere conto di questa complessità perché mettono in evidenza soprattutto limiti e mancanze più che dimensioni desideranti e risorse (…)
E’ possibile parlare di progetto di vita solo all’interno della realtà, cioè di qualcosa che ci precede, ci istituisce e che cambia, o almeno può cambiare, anche grazie al nostro contributo. La realtà è il più importante ed efficace dispositivo formativo per tutti, comprese le persone con disabilità, per i suoi aspetti di molteplicità, mutevolezza, varietà, imprevedibilità. Alimenta possibilità identitarie praticamente infinite (…)
Aiutare i familiari a non sostituirsi. I familiari che hanno in casa una persona con disabilità complessa sviluppano e affinano nel tempo una sensibilità in grado di intercettare e cogliere le istanze del congiunto, leggendo e interpretando segnali e comportamenti che per altre persone possono apparire privi di significato. Diventano di fatto degli esperti di comunicazione con chi vive con una disabilità impegnativa; non di rado sono loro a orientare le figure professionali che accostano il loro figlio nelle fasi iniziali di queste relazioni.
Come tutte le medaglie è il rischio che il genitore, un po’ alla volta, si costruisca un quadro delle condizioni e delle attese del figlio che può staticizzarsi, riducendo la capacità di percezione e di attenzione nei suoi confronti. Il rischio è che prevalga un orientamento alla sostituzione più che all’ascolto, in funzione della percezione della fragilità e della vulnerabilità delle condizioni esistenziali, particolarmente critiche quando si parla di disabilità complesse. Da questo punto di vista il dialogo con interlocutori esterni (altri familiari, operatori, servizi..) è una risorsa importante che può essere d’aiuto nel rendere possibile un’attenzione non pregiudiziale, e aprire possibilità conoscitive e relazionali nuove, che si basano su quanto capito nel passato, ma che non ne rimangono prigioniere (…)
L’orizzonte del desiderio chiede ai servizi un passo avanti rispetto alla storia che li ha caratterizzati e che li ha portati a diventare strutture nelle quali le persone con disabilità passano la vita. Questa strada ha comportato un serio rischio di deriva tecnicistica che, a sua volta, si è rivelata un ostacolo notevole alle possibilità di soggettivazione delle persone prese in carico (…)
Quindi la prospettiva non è quella di azzerare i servizi ma di riorientarli: non punti di arrivo della vita della persona con disabilità ma punti di partenza e di regolazione di percorsi esistenziali che in parte si possono svolgere al loro interno, ma in buona parte possono costruirsi al di fuori, anche quando c’è di mezzo una disabilità complessa.